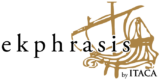“Essere un fotoreporter richiede esperienza, abilità, resistenza, energia, abilità nel saper trattare, capacità organizzative, saper adulare, scalare, sapersi imbucare, ecc. – in più, non guasta avere un certo occhio e tanta pazienza”.
Ruth Orkin
Queste le parole con cui la fotoreporter e cineasta americana Ruth Orkin definisce il proprio mestiere, stampate quasi come una sorta di epigrafe sulle pareti dei Musei Civici di Bassano: questa frase riassume e restituisce tutte le diverse componenti che entrano in gioco nella sua carriera di fotografa, esattamente come riesce a fare la mostra attualmente in corso tra le sale del museo. Organizzata in collaborazione con diChroma photography in occasione del centenario della nascita della Orkin, si tratta della prima retrospettiva italiana a lei interamente dedicata, unica tappa italiana di un tour europeo, che proseguirà poi a San Sebastian, in Spagna, e a Cascais, in Portogallo
Un vero e proprio evento, dunque, per il mondo della fotografia, annunciato fieramente dalla nuova direttrice dei Musei Civici Barbara Guidi: «Sono molto lieta di presentare l’opera di questa protagonista della fotografia del Novecento. La sua capacità di fondere assieme, in un’alchimia perfetta e misteriosa, la forza coinvolgente del racconto e la freschezza dell’attimo catturato al volo, fa di lei una delle artiste tra le più affascinanti del secolo scorso».
La mostra si sviluppa attraverso due grandi sale che ripercorrono e celebrano tutte le tappe della carriera della fotografa: centoventi tra i suoi più celebri scatti – da “VE-Day” a “Jimmy racconta una storia”, da “American Girl in Italy” ai ritratti di Robert Capa, Marlon Brando e Woody Allen – testimoniano il talento di Orkin nell’estrapolare dal flusso della vita attimi apparentemente fugaci ma capaci di diventare iconici, di restituirne la potenza evocativa e farne le parole di una narrazione. Quelli di Orkin non sono semplicemente ritratti o paesaggi, ma vere e proprie storie, racconti in cui luoghi e persone si intrecciano, parlano e rispecchiano l’uno nell’altro.
Non è un caso che il linguaggio cinematografico abbia un ruolo centrale nella poetica della Orkin: figlia d’arte, Ruth crebbe sotto l’ala della madre, un’interprete di film muti, Mary Ruby, nella Hollywood degli anni 20 e 30 del Novecento, i cosiddetti anni d’oro. Il cinema sarà così un’ombra sempre presente in tutta la sua produzione artistica, nella quale si fondono i punti di forza delle due arti: spontaneità e teatralità, attimo e racconto. Ciascun fotogramma è così capace di narrare una storia.

La dialettica cinema-fotografia è un fil rouge che accompagna tutta la sua vita. A dieci anni riceve la prima macchina fotografica, una Univex da 39 cents che per la giovane Ruth rappresenta uno dei due mezzi di cui dispone per il proprio progetto di vita e di emancipazione: quello di diventare regista cinematografica, una carriera al tempo preclusa alle donne. Il secondo strumento è una bicicletta: nel 1939, a diciassette anni, pedala fino a New York per visitare la grande Esposizione Internazionale di quell’anno. Con la macchina fotografica ritrasse persone e luoghi incontrati durante quell’avventura solitaria, e ne trasse un diario di viaggio, esposto in mostra.
Il suo bisogno di libertà e autonomia si riflette nel modo in cui ritrae i suoi soggetti: non c’è alcuna invadenza, nessuna pressione; al contrario, si percepisce il desiderio di passare accanto al soggetto, sfiorandolo semplicemente con lo sguardo. Questo vale tanto per il suo diario di viaggio quanto per la produzione successiva: le persone vengono fotografate mentre aspettano il treno o stanno sedute al tavolo di un bar, immerse nei loro pensieri. La fotografa si pone ad una distanza di sicurezza, per non violare quei momenti di intimo isolamento. Come lei stessa dichiara nella sua autobiografia, di cui in mostra si possono leggere alcuni estratti:
“Preferisco che i miei soggetti non sappiano che mi trovo lì, e che siano troppo indaffarati per accorgersi della mia presenza. Mi sforzavo di non muovermi a meno che non fosse assolutamente necessario e di non premere il pulsante dell’otturatore a meno che non ci fosse un rumore che copriva il suono, anche a costo di perdere lo scatto. Essere accettata dal soggetto era ciò che contava. C’era sempre il modo di realizzare un altro scatto. Lo chiamavo “confondersi con la tappezzeria”.
Ruth Orkin
Quelle che cerca sono persone immerse nella loro quotidianità: signore che danno da mangiare ai gatti di strada, due bambine che giocano a farsi volteggiare, un venditore di angurie: una poetica delle piccole cose che vince la sfida del tempo e diventa traccia duratura della vita nella sua semplicità.

Dopo aver studiato per un breve periodo fotogiornalismo presso il Los Angeles City College, sperando di poter lavorare come regista per la Metro Goldwin Mayer, Ruth deve tuttavia fare i conti con l’ambiente sessista del tempo. Se dunque si trova costretta a rinunciare al proprio sogno, quello che però non può fare è abbandonare la propria vocazione, per lei una vera e propria necessità interiore: quella di raccontare il mondo. Per farlo, la fotografia diventa l’unica strada da percorrere e nel 1943 si trasferisce a New York, dove lavora come fotografa in un locale notturno.
Uno stralcio dell’autobiografia racconta i suoi primi passi: “Non ho mai avuto a disposizione una camera oscura con lavello, acqua corrente, oscuramento completo e spazio a sufficienza per lavorarci comodamente. La maggior parte delle mie stampe professionali è stata in questo monolocale su Horatio Street che condividevo con Jane Gaitenby. Nel 1950 avevo una sistemazione analoga in una camera da letto sacrificata in un bilocale sulla 53rd Street West. L’ingranditore era in cucina – praticamente eravamo costretti a mangiare in piedi, stile buffet”.
Queste condizioni precarie saranno però presto solo un ricordo: quella della Orkin è una carriera folgorante, che la porta a scattare per i maggiori magazine del tempo diventando una delle firme femminili più importanti della fotografia.
Accanto ai lavori per il LIFE, New York Times e altre celebri testate, Orkin tuttavia continua il suo personale viaggio nella quotidianità dando vita a progetti come “A World Trough My Window”, con il quale racconta semplicemente ciò che scorre sotto le finestre del suo appartamento in Central Park (adottando un inusuale punto di vista dall’alto, quasi perpendicolare, che dimostra la conoscenza della fotografia documentaria tedesca degli anni 30 derivata dalle sperimentazioni del Bauhaus, come quella di Otto Umbehr).
Nel 1953 il sogno di una vita diventa finalmente realtà: insieme al marito Morris Engel e al regista Ray Ashley dirige Il piccolo fuggitivo, film vincitore del Leone d’Argento al Festival del Cinema di Venezia, anch’esso proiettato in mostra.
Non manca all’appello tra le sale bassanesi neppure quello che è considerato una vera e propria icona della fotografia del Novecento (nonché secondo poster più venduto al mondo): “American Girl in Italy”, racconto fotografico dell’esperienza di una giovane studentessa di storia dell’arte americana in viaggio nell’Italia del dopoguerra (anche in questo caso i riferimenti cinematografici non mancano: gli scatti evocano l’atmosfera dei film americani degli anni Cinquanta, “Vacanze romane” in primis). La Orkin dimostra ancora una volta di saper cogliere con il suo obiettivo situazioni iconiche e trasformarle nelle parole di un raccolto coinvolgente, degno dei migliori registi.
“Si può essere poeti senza scrivere mai una poesia, poiché per la poesia fatta di immagini, luoghi, persone, attimi strappati all’eternità, è sufficiente una macchina fotografica, talento e sensibilità artistica”.
Ruth Orkin