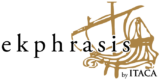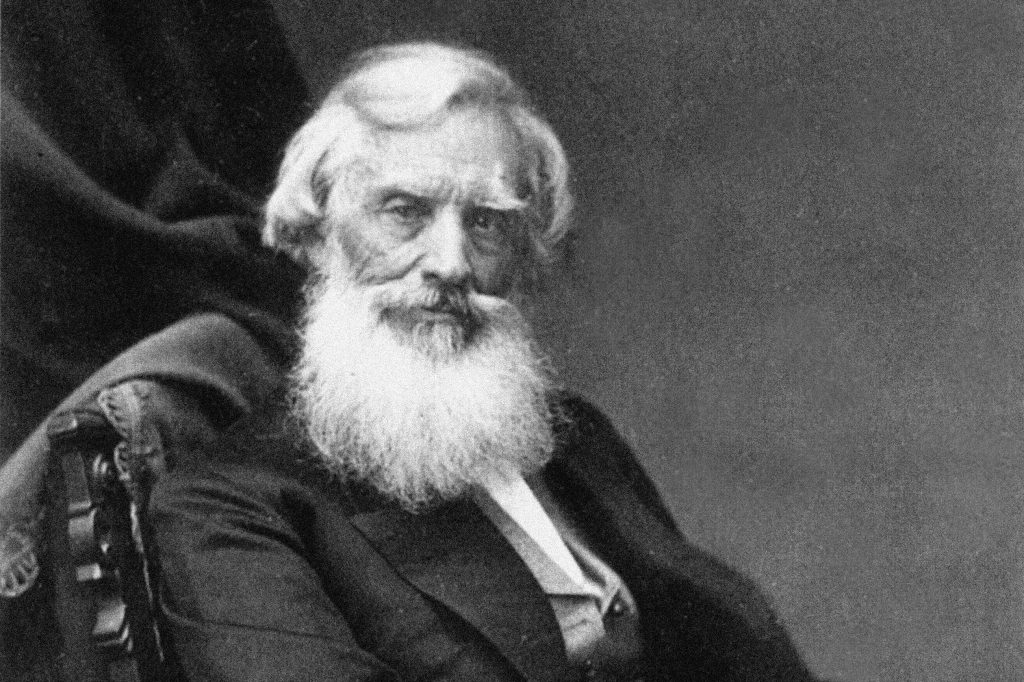C’era una volta il 1968. Dai bollori del maggio francese, che avevano traversato anche le spiagge di Cannes, causando l’interruzione anticipata del Festival, la contestazione arriva anche in Italia, irrompendo sui nostrani lidi della Biennale d’Arte e della Mostra d’Arte Cinematografica. La divisione in premi, lo Statuto ancora di impostazione fascista della kermesse cinematografica, sono due dei punti che l’Associazione Autori Cinematografici (Anac), sull’onda delle rivolte studentesche che imperversano tra le acque della laguna e i giardini della Biennale, attaccano aggressivamente.
C’era una volta, tra i membri dell’Anac, Pier Paolo Pasolini. Le posizioni dell’intellettuale friulano sul Sessantotto («Quando ieri a Valle Giulia […] … »), provocatorie e provocate sono passate alla storia come fraintese, equivocate, e per questo negli anni contestualizzate e problematizzate. Per quanto Pasolini non si sia trovato dans la rue a partecipare e a filmare famelico come il suo cineasta poetico Jean-Luc Godard, ci teniamo a rovesciare, nella costruzione del tempo di questo Once upon a time, l’epigrafe sopra citata e accennata sugli scontri di Valle Giulia a Roma, con i versi del poemetto autobiografico Coccodrillo:
Ebbe la prima vera crisi della sua vita. Perché? Perché per la prima volta si rese conto di essere un padre […] Ma per me, celibe, che cosa significò tutto questo se non che i miei figli erano come i miei padri?
Pasolini comunque, di quell’edizione burrascosa del Festival veneziano non è solo spettatore – ma forse, lo è mai voluto essere? – come durante i tafferugli romani: per quell’anno è previsto in concorso anche il suo Teorema, stavolta non accompagnato dal produttore Alfredo Bini come era stato fino al precedente Edipo re [1967].

In questa fiaba allora, C’era una volta anche Teorema: il film di Pasolini del 1968 è una storia che procede parallela a quella che qui si sta dispiegando; se le domande dei versi di Coccodrillo sembrano oscillare pericolose e tombali sopra le immagini del successivo Porcile [1969], tra gli amplessi di Julien Klotz/Jean-Pierre Léaud con i maiali e nell’unica frase pronunciata dal cannibale di Pierre Clémenti «Ho ucciso mio padre, ho mangiato carne umana, tremo di gioia», il vento del maggio soffia già, più caldo, nella pellicola destinata al lido. Teorema si incastona nella filmografia pasoliniana mitica di quegli anni, tra lo stesso Edipo re e Medea [1969], in quel ricorso al mitico e al mistico, unico riparo per un sacro a lungo cercato tra le civiltà contadine e le realtà sottoproletarie, ora entrambe violentate dall’inarrestabile omologazione borghese. L’Edipo di Franco Citti era infatti stato un re di Tebe non colpevole, disposto a combattere per dimostrare la propria innocenza contro il mito e le sue profezie, e destinato inesorabilmente a soccombere; La Medea di Maria Callas invece, al giro di boa verso gli anni Settanta degli Scritti corsari, si presenterà di per sé già sconfitta, regina di una Colchide palustre dove la sacralità si consuma tra le parole a lei rivolte dal centauro Chirone: «solo chi è mistico è realistico e solo chi è realistico è mistico». Nei due poli definiti dagli adattamenti di Sofocle ed Euripide, Teorema è la pietra grezza: nel mito non si cerca il riparo, ma anzi, tragedia classica e reale si violentano a vicenda. Nel microcosmo borghese che ha determinato lo sterminio del sacro, il mito non si adatta, si inscena; il dionisiaco ospite di Terence Stramp porta l’ambiguità delle Baccanti, provoca lo sconvolgimento del nuovo reale imponendogli tutta la carica mistica dell’ultima tragedia di Euripide, una sorta di rito orgiastico tra i due piani che trova il suo riflesso nella sensualità dell’ospite. Non c’è innocenza colpevole (almeno, non in un’analisi in prima battuta) nella pellicola del Sessantotto di Pasolini; la provocazione delle parole su Valle Giulia, l’apparato ideologico di Coccodrillo e quello politico dell’attività corsara sono, alla seconda incursione cinematografica nel mito classico, prima di tutto contenute nei corpi e nel loro apparire, splendere, incontrarsi. Mentre il Sessantotto ribolle, la fabula di Teorema arde ancora di sensualità, grida attraverso la carne la sua difesa del sacro, innalzandosi come Laura Betti nel finale del film.


Gli attacchi dell’Anac, di contro, sono precisi e diretti, in linea con le istanze politiche della contestazione. Il cortocircuito tra le due fiabe – quella del film che deve passare al Festival, e al Festival che deve essere ribaltato dalle fondamenta – si consuma così per Pasolini nella sua attività pubblicistica dei giorni precedenti all’apertura della Mostra, dove si legge tutto il dilemma sul partecipare o meno: in una dichiarazione a “Paese Sera” si esprime sulla «urgente» revisione dello Statuto fascista, ribadendo però contemporaneamente sulle pagine del “Giorno”, la volontà di presentare il film, opponendosi al «fascismo di sinistra», andato a delinearsi proprio in seno al clima di insofferenza. Un nuovo tipo di di conformismo, rifugio dei finti giovani moralisti e dei veri giovani borghesi, che agisce sotto il segno dell’intimidazione.
L’intreccio della fiaba “Venezia ’68” si snoda ancora attraverso l’occupazione da parte di autori e critici dell’Associazione, spalleggiati da studenti e intellettuali che intanto manifestano lungo le calli Veneziane e per le strade del lido, della Sala Grande del Palazzo del Cinema e il ritiro di tutte le pellicole dal concorso. Prosegue poi, per Pasolini, alle esigenze distributive di un produttore, Franco Rossellini, ben diverso dal fidato Bini che, come titolavano i cartelli dell’Overture morriconiana di Uccellacci e uccellini [1966] «producendo rischiò la sua posizione», fino alla conferma, voluta proprio dalla produzione, della presenza di Teorema al Festival.
Come ogni fiaba che si rispetti, anche queste hanno la loro conclusione (se morale, non ci sentiamo di dirlo): l’avventura di Teorema alla Mostra del Cinema di Venezia e quella del contenuto del film trovano la loro sintesi nella censura da cui questo è colpito, attaccato violentemente dalla Chiesa e processato «per oscenità e per le diverse scene di amplessi carnali alcune delle quali particolarmente lascive e libidinose», prima dal Tribunale di Roma, poi da quello di Genova e giudicato infine per «competenza territoriale» da quello della Venezia regno di Festival e Leoni. Due fiabe quindi, che nello sbroglio dei loro eventi trovano una sintesi nel paradigma Pasolini: Censura. Perché malgrado la «censura fascista» che l’intellettuale vede perseguitarlo da quando osava scrivere in dialetto nella sua prima raccolta Poesie a Casarsa, e malgrado lo Statuto fatto della stessa pasta che lui e gli altri membri dell’Anac vorrebbero sradicare, Teorema dei premi li vince: la reale baccante Laura Betti ottiene la Coppa che porta il nome del Conte Volpi fondatore della Mostra alla miglior interpretazione e l’ala più progressista della chiesa assegna al film il premio Ocic (Office Catholique International du Cinèma).

Il C’era una volta… Teorema al Festival è allora forse a sua volta una matassa, quella fatta dei nodi intrecciati del Pasolini contestatore e contestato, polemico e in polemica, vilipendiato per vilipendio, osceno e scandaloso fin dai Ragazzi di vita, sensuale e politico, mitico e ideologico, sempre vincitore dei processi dove le assoluzioni provano che «Lo sconvolgimento che Teorema provoca non è affatto di tipo sessuale, è essenzialmente ideologico e mistico. Trattandosi incontestabilmente di un’opera d’arte, Teorema non può essere sospettato di oscenità». Come i pallidi riflessi che le acque delle laguna, dove presto sbiadirono anche i fuochi della contestazione, la dialettica che rimbalza tra un Pasolini provocatorio sui fatti di Valle Giulia, ideologico tra i versi di Coccodrillo, mitico e sensuale dietro alla scrittura e alla macchina da presa di Teorema, combattivo e rivoluzionario ai cancelli del Palazzo del cinema, è sempre destinata a ritornare: è la stessa dell’intellettuale che sa nel j’accuse delle pagine che compongono il Romanzo delle stragi; il romanziere che riversa con paura e fervore le sue indagini in quelle di Petrolio; l’uomo che cade invocando le madre in una notte di novembre all’Idroscalo di Ostia; il regista che sradica dalla sua camera ogni forma d’innocenza e di sacro per il cosmo senza pietà di Salò [1975], lasciandovi solo corpi non più dionisiaci che la postuma censura etichetterà «aberranti e ripugnanti di perversioni sessuali che offendono sicuramente il buon costume». Le fiabe, per funzionare, si ripresentano sempre con la stessa identica struttura.