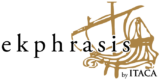Tutti noi conosciamo le iconiche scarpe della Nike, ma sappiamo da dove nasce il celebre Swoosh ricamato sul fianco destro delle sneakers? Il logo viene disegnato nel 1971 da Carolyn Davidson, studentessa di design alla Portland State University. In questo caso, come spesso accade nella storia e nella storia dell’arte, si applica il principio del de nihilo nihil, per cui l’espressione grafica del fruscio del vento vento è stata ispirata dalle ali spiegate della splendida Nike di Samotracia.

Il successo di molti prodotti è legato ad un’immagine capace di rappresentarli: il brand. L’etimologia di “brand” deriva dal nordico “brandr”, ovvero “bruciare, marchiare a fuoco vivo” e secondo la definizione più consolidata e discussa, data dall’American Marketing Association, si tratta di “un nome, un termine, un segno, un simbolo o qualunque altra caratteristica che ha lo scopo di far identificare i beni o i servizi di un venditore e di distinguerli da quelli degli altri”. L’importanza del brand è ritenuta una cifra interpretativa del mondo contemporaneo e se agli albori della società industriale ha rappresentato una specie di scorciatoia per far conoscere la merce al consumatore, nel capitalismo avanzato la marca è divenuta un mezzo grazie al quale le aziende fanno in modo che i clienti se ne innamorano anche a costo di ignorare qualità e prezzo (esperienza direi comune a tutti noi, oggi).
Il place branding è divenuto progressivamente una delle frontiere potenzialmente più forti non solo per le aziende, maanche per amministrazioni e cittadini. La reputazione di un luogo e della sua comunità vale quanto il capitale sociale per un’azienda: lo sanno bene molte città che hanno intensificato la politica di brand per rigenerare quella che si può considerare come “artiglieria immateriale della seduzione simbolica”.
Uno dei marketing territoriali più famosi di sempre, se non il più famoso, è quello messo in atto dalla città di New York: I Love NY. Questo piccolo e semplice logo è diventato parte integrante della cultura di massa, non solo dei newyorkesi, ma del mondo intero. Adesso New York non avrebbe bisogno di “farsi pubblicità”, eppure negli anni ’70, quando è iniziato il branding, la città aveva una pessima reputazione. Alcuni film di quegli anni, come The Warriors di Walter Hill (1979) e Taxi Driver di Martin Scorsese (1976), riflettono le problematiche che affliggevano la città e portano sulla scena una NYC sporca, oscura e problematica.
È il 1977 quando si decide che bisognava fare qualcosa per ribaltare la cattiva reputazione della città. L’inconfondibile logo di New York come lo conosciamo ancora oggi, nasce dall’idea di Milton Glaser di dare nuova forma al già esistente progetto di Charles Moss. I Love NY, con le lettere I N Y incise in caratteri neri e un cuore rosso ciliegia al posto di “love”, fu una rivoluzione per la città e per i cittadini stessi, che iniziarono a sentirsi comunità e a sviluppare un orgoglio che oggi è parte integrante di ogni newyorkese.

Una versione speciale apparse per un po’ nel 2001, divenendo anche la copertina del Daily News: “I Love NY More Than Ever” (Amo New York più che mai), con una cicatrice nera sul cuore rosso. Anche dopo che il Covid ha colpito duramente la città, il logo “speciale” è stato rispolverato per ricordare a tutti che New York può affrontare qualsiasi cosa. In pochi caratteri il logo racchiude parole ed emozioni in modo immediato e simbolico. Stampato su t-shirt, tazze e gadget di ogni tipo, oggi il marchio genera profitti che superano i 30 milioni di dollari l’anno (e pensare che venne realizzato pro bono!). Glaser, che nel 2009 ricevette il premio National Medal of Art dal Presidente degli USA in carica Barack Obama, è considerato il creatore di una nuova forma di comunicazione chiamata social design: un design su misura della società. In un’intervista al New York Times, Glaser afferma:
“Sapevo che quello che stavamo comunicando era qualcosa che teneva insieme le persone, che stabiliva per loro un modo di comunicare”.
Quando pensiamo ad un luogo, ad una destinazione turistica, ci riferiamo ad un’immagine virtuale definita come l’insieme di credenze, idee, informazioni più o meno mediate che il luogo ha sulla scena mainstream. L’immagine del luogo si forma attraverso il place personality, cioè la comprensione delle caratteristiche di base e della vocazione territoriale della destinazione, e attraverso il place making, ovvero tutte le azioni messe in atto dai diversi soggetti per riuscire a rappresentare il territorio. Su questo ultimo, a partire dal secondo dopoguerra, ha iniziato a giocare un ruolo chiave il cultural branding, come nel caso di New York City. Gli attori locali si impegnano nella co-produzione di immaginari, perché questi garantiscono la possibilità di attrarre investimenti finanziari e localizzazioni: gli aspetti organizzativi, sociali e identitari, che hanno consentito la massificazione del turismo, hanno contribuito anche a farne un potente motore di trasformazione produttiva territoriale (con la cultura si mangia, eccome!).
L’immagine degli anni Settanta di una New York dalle strade nere segnate dal rosso sangue non è altro che uno strascico degli effetti atomici del secondo dopoguerra. Si tratta di un periodo di contrasti: nelle fotografie storiche di queglianni troviamo, da un lato, ammassi di macerie e dall’altro, accanto, grattacieli espressione della tecnica dell’innovazione. La rinascita dell’economia territoriale punta soprattutto sul settore turistico. Come abbiamo di sopra visto per il caso di New York, anche nel Vecchio Mondo si applicano le medesime strategie di cultural branding per divenire mete delle nuove rotte del turismo di Massa. Per quanto riguarda il territorio veneto, approfondiamo in questa sede il caso di Verona.

Il capoluogo di provincia si trova nella parte settentrionale della Pianura Padana, ai piedi dei monti Lessini ed è attraversata, nel suo cuore, dal fiume Adige. Il centro storico della città è stato inserito nel 2000 (dopo un lungo processo iniziato nel 1995) nella World Heritage List, con la denominazione generica di “City of Verona”. Una grande conquista, dal momento che la città può essere considerata, come moltissime altre nel nostro Paese, come un Museo all’aperto. I punti di maggior interesse turistico nel centro storico sono certamente gli edifici risalenti all’epoca romana, che a Verona non solo sono conservati egregiamente, ma continuano a far parte della vita quotidiana degli abitanti: se il Ponte Pietra, il Teatro romano, l’Arco dei Gavi, Porta Borsari, e Porta Leoni continuano ad essere delle infrastrutture dello spazio cittadino, il celebre anfiteatro Arena dal 1936 propone un florido calendario di spettacoli lirici e concerti che attraggono ad ogni stagione migliaia di spettatori. Altri importanti monumenti e opere architettoniche che caratterizzano la città risalgono al periodo comunale e in particolare alla fase del governo Scaligero: in questo periodo il centro viene circondato dalle mura, sorge il Castello di San Martino in Aquaro (cosiddetto Castelvecchio), si moltiplicano le torri – Torre dei Lamberti, Torre del Gardello – così come i monumenti funebri noti come Arche Scaligere. Sotto il dominio veneziano vengono poi costruiti nuovi edifici in stile rinascimentale ad opera soprattutto del famoso architetto veneto Michele Sanmicheli. Egli si occupa della nuova struttura urbana, delle mura bastionate con porte monumentali quali Porta Vescovo e Porta San Zeno, di palazzi come Palazzo Maffei o del Capitano e anche di numerosi interventi all’interno delle chiese. Grazie alla presenza austriaca ottocentesca, Verona diventa una vera e propria città fortezza: vengono costruite le mura bastionate, un arsenale, viene instaurata una provianda nell’ex convento di Santa Marta (oggi campus economico dell’Università degli Studi di Verona) ed edifici militari di vario genere come Castel San Pietro, un’imponente fortezza costruita in cima al colle dove ebbe origine Verona, Forte San Lorenzo, Palazzo Barbieri (dove aveva sede il comando austriaco), il Cimitero Monumentale e l’Ospedale Militare.
“There is no world outside the walls of Verona, but only purgatory, torment and hell. He who is banished from here is banished from the world, and banishment from the world is death.”
La citazione è tratta dalla scena II dell’Atto III della più famosa delle opere che William Shakespeare ambientò a Verona Romeo e Giulietta. Il drammaturgo inglese ambientò ben cinque dei suoi drammi in Veneto, nonostante non ci fosse mai stato: “Il Mercante di Venezia” e “Otello”, pubblicati rispettivamente nel 1600 e nel 1604, sono ambientati a Venezia, “La bisbetica domata” (1594) a Padova e “I due gentiluomini di Verona” e “Romeo e Giulietta”, 1623 e 1594, a Verona. Shakespeare descrisse tutte queste città secondo l’ottica elisabettiana a lui contemporanea, per la quale, spesso l’Italia era considerata terra di tradimenti, di veleni, di complotti. Compose Romeo e Giulietta tra il 1594 e il 1596. La tragedia, sin dalla sua pubblicazione diede origine a quello che si può definire uno dei più grandi miti romantici della cultura occidentale: la storia di un amore perfetto ma avversato dalla società e quindi finito in tragedia.
La vicenda non era priva di fondamento storico, infatti nel periodo medievale, Verona fu scenario di forti scontri interni tra le famiglie nemiche di parte guelfa e di parte ghibellina, tra cui figurano anche i Montecchi e i Cappelletti (Capuleti nella tragedia di Shakespeare). Tanto che Dante Alighieri in un passo del canto VI del Purgatorio racconta:
“Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom senza cura: color già tristi, e questi con sospetti!”
Nel primo Novecento il diffondersi europeo dei sentimenti nazionalisti coinvolse anche l’Italia: il comune di Verona cavalcò l’onda del revival medievale e la fama internazionale, dovuta ai drammi shakespeariani, per strutturare il mito dei due amanti. Nel 1907 il comune acquistò dalla famiglia Failler la casa dei Dal Cappello sita oggi in Via Cappello n° 13. Con l’acquisto della casa vennero subito compiuti i primi riadattamenti del fabbricato per favorire la visita ai turisti, che già nella metà dell’800 si lamentavano dello stato di abbandono in cui si trovava il sito. Ma gli effettivi lavori che portarono alla restaurazione dell’edificio esterno nel suo attuale aspetto iniziarono nel 1940: l’allora direttore dei musei civici Antonio Avena fu il promotore di questa operazione che oggi potremmo definire a tutti gli effetti come “falsificazione architettonica”. Vennero aggiunti alla struttura originale elementi decorativi in un ipotetico stile rinascimentale, senza una ricerca filologica e secondo un criterio puramente estetico: dal rosone gotico alle finestre trilobate quattrocentesche. L’intervento più iconico fu l’aggiunta, al primo piano, del famosissimo balcone: in una fotografia del 1926 esso appare a terra, nel cortile del Museo di Castelvecchio, si trattava infatti di un antico sarcofago scaligero.


Sul muro di fondo del cortile è stata collocata nel 1972 una statua in bronzo raffigurante la bella Giulietta realizzata da Nereo Costantini. La seconda tappa della leggenda è la Casa di Romeo, che fin dal XIX secolo venne identificata nel complesso medievale in Via Arche Scaligere e indicata come casa dei Montecchi. Ci fu un tentativo da parte del Comune di Verona, su progetto di Antonio Avena, di acquistare tutto lo stabile per farlo diventare la sede della Soprintendenza e di un museo Shakespeariano, ma i proprietari e il Ministero non acconsentirono al progetto. La “casa di Romeo” ad oggi può essere vista solo dall’esterno.

Infine, nel 1938 Antonio Avena collocò nell’ex convento di San Francesco al Corso, oggi sede del Museo Civico, il sarcofago di marmo rosso noto come Tomba di Giulietta: il luogo era già meta di pellegrinaggi nell’Ottocento ma con questa azione di oggettificazione della leggenda il set di brandizzazione della città degli innamorati fu completato: in questo modo la città fu pronta per presentarsi come palcoscenico ideale per numerosi adattamenti e richiami cinematografici, dal “Romeo and Juliet” del 1936 diretto da George Cukor, al “Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli del 1968, sino al netflixiano “Love in the Villa” del 2022 di Mark Steven Johnson.

In queste vesti, Verona diventa una meta privilegiata dai primi flussi del turismo di massa: il cultural branding attraverso cui viene attirato il visitatore medio ruota attorno al tema della “Città dell’amore”.
Oggi, nelle tabaccherie e cartolerie del centro, nelle bancarelle sparse nelle piazze e negli shop dei musei il brand “Romeo e Giulietta” è al primo posto. Ogni anno decine di migliaia di innamorati scrivono delle lettere indirizzate a Giulietta, la figura dell’amore per eccellenza, generando un fenomeno eccezionale che rende sempre di più Verona la città dell’amore. Tutte queste lettere vengono ricevute dal “Club di Giulietta”, composto da una squadra di volontari che rispondono come “Giulietta” ad ogni singolo mittente.
Il problema, per il caso di Verona, è il non parallelismo tra place branding e social branding; mi spiego meglio: mentre nel caso di New York il brand esprimeva l’immagine che della città volevano dare i suoi cittadini – una città sicura, nuova, all’avanguardia – per Verona l’immagine turistica della città è ridotta al brand.
Esaminiamo nel concreto un paio di questioni rilevanti al riguardo: abbiamo detto che Verona è iscritta nella WHL dal 2000, questo riconoscimento è stato ottenuto non in quanto “città letteraria”, ma citando la Dichiarazione di valore:
“Per la sua struttura urbana e per la sua architettura, Verona è uno splendido esempio di città che si è sviluppata progressivamente e ininterrottamente durante duemila anni, integrando elementi artistici di altissima qualità dei diversi periodi che si sono succeduti; Verona rappresenta in modo eccezionale il concetto della città fortificata in più tappe caratteristico della storia europea.”
Parafrasando, la città è Patrimonio dell’Umanità per la sua struttura urbanistica e in particolare per il sistema di mura e fortificazioni. Eppure, il Parco delle Mura, non è gestito direttamente dal comune ma, per il tramite di Legambiente (https://www.legambienteverona.it/parco-mura/) e inoltre privo di una sede fisica di riferimento, per non parlare della mancanza di indicazioni o merchandising nelle botteghe cittadine.
Leggendo la tabella con i numeri dei visitatori annui dei Civici Musei Veronesi (pubblicati in data 20 gennaio 2023 su L’Arena: https://www.larena.it/territorio-veronese/citta/musei-verona-calo-visitatori-1.9845953), notiamo che, subito dopo l’Arena, la Casa di Giulietta scarta di molto il Museo di Castelvecchio.
Per chi è appassionato di arte e conosce anche solo vagamente il nome di Licisco Magagnato e Carlo Scarpa ciò è inspiegabile.
Il Castello che oggi ospita il museo fu costruito tra il 1354 e il 1356 per disposizione di Cangrande II della Scala con ragione difensiva, ma per un breve periodo fu anche luogo di residenza dei Della Scala. Nell’Ottocento, dopo il passaggio allo Stato italiano, rimase caserma fino a quando, nel 1924, grazie al direttore dei musei civici Antonio Avena e all’architetto della Soprintendenza Ferdinando Forlati, venne realizzato un restauro in stile medievale e fu reso sede delle collezioni civiche. Durante la Seconda guerra mondiale Verona fu duramente bombardata e il castello e il ponte annesso subirono gravi danni strutturali che portarono alla chiusura della struttura. Nel 1956 il giovane Licisco Magagnato, che aveva appena vinto il concorso per la direzione dei musei civici, incaricò Carlo Scarpa del restauro e dell’allestimento del Museo. Le operazioni durarono fino al 1964 e il museo ne uscì rinato. Ad oggi, il restauro scarpiano di Castelvecchio è uno dei più alti esempi di architettura museografica italiana del secondo Novecento: a chiusura perfetta della nuova struttura, issata su un alto basamento in calcestruzzo, si trova la statua equestre di Cangrande della Scala che, con il suo sorriso, abita in eterno il suo Palazzo.


Per indirizzare correttamente una campagna di cultural branding occorre una forte base di conoscenza storica e filologica dei luoghi che si intende promuovere e una forte consapevolezza degli obiettivi che si intendono raggiungere per far fronte al rischio massmediale della degenerazione del branding. La promozione di massa può portare ad una fruizione acritica della cosa di interesse culturale, rendendola equiparabile ad una particolare marca di sneakers da preferire ad un’altra sulla base di motivazioni ingiustificate e non chiare, prive di fondamento e quindi di facile scadenza, le quali portano alla trasformazione dell’Heritage in Capital.
Oggi abbiamo coscienza del potere distruttivo di questa dinamica, è quindi un dovere utilizzare il cultural branding per incuriosire, badando bene a non renderlo l’immagine dominante e lapidaria di una realtà; lasciando che il singolo, visitatore o cittadino, appassionato o occasionale interessato, crei in modo consapevole e libero lo spazio della città.