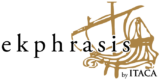Si parla troppo poco, e male, nel nostro Paese, di un conflitto che va avanti dal secolo scorso ed è ben lontano dall’essere risolto diplomaticamente o militarmente: quello portato avanti dalla Turchia ai danni della comunità curda in Medio Oriente. La premessa dello scontro ha origini remote: la minoranza etnica curda reclama un proprio Stato da secoli, ma solo nel dopoguerra, con la spartizione dell’Impero Ottomano, sembra arrivare in più circostanze un appoggio degli Stati Uniti per la concretizzazione del progetto. Tuttavia, il mancato rispetto delle promesse fatte e l’opposizione turca alla creazione di uno stato autonomo confinante, hanno avuto come diretta conseguenza la spartizione della regione del Kurdistan tra quattro stati (Siria, Iraq, Turchia e Iran) ai danni di una minoranza etnica e religiosa di quaranta milioni di persone; la frattura si è poi ulteriormente allargata negli ultimi anni, sia con l’appoggio turco agli americani nella lotta all’ISIS che con la richiesta di aiuto da parte di questi ultimi ai curdi siriani per la liberazione della Siria del nord.
Si tratta di dinamiche a cui assistiamo passivamente, ma nelle quali giovani donne e uomini, abitanti di quei territori, scelgono di mettere a rischio la propria vita quotidianamente, difendendo e facendo propri ideali quali democrazia, liberazione femminile dalle costrizioni del patriarcato, ridistribuzione del reddito, autodeterminazione dei popoli ed ecologia sociale. Si tratta, d’altra parte, dei valori fondanti del Confederalismo democratico, quel paradigma politico-sociale teorizzato nel 1978 e portato avanti da Abdullah Ocalan, leader del PKK (partito dei lavoratori curdo), detenuto da circa vent’anni nel carcere di massima sicurezza di Imrali, in quanto oppositore politico del regime turco. Il popolo curdo, a differenza di paesi che sembrano star facendo passi indietro in questo senso, promuove e pratica quotidianamente la convivenza pacifica di popoli di etnie, religioni, lingue diverse e sono moltissimi gli “internazionalisti” e le internazionaliste”, giovani provenienti da tutto il mondo, a scegliere di dare il proprio contributo alla loro causa di liberazione.

Viene da chiedersi come possa essere restituito adeguatamente uno scenario così complesso. Dal punto di vista mediatico la narrazione di ciò che sta accadendo è stata ed è spesso contaminata da pregiudizi, retorica, propaganda, giochi di potere, tutti elementi che hanno inquinato il contributo positivo dato alla causa, recentemente, anche da parte di alcuni nostri giovani connazionali (Edgarda Marcucci, Jacopo Bindi, Paolo Andolina); dalle parole dei protagonisti, espresse tramite i social o nell’ambito di dibattiti sul tema, è chiaro quale sia stato il presupposto della loro partecipazione: da una parte, la volontà di dare un contributo alla liberazione di un popolo oppresso, dall’altra l’aspirazione a creare un modello sociale nel quale identificarsi per riproporne le caratteristiche anche nel nostro Paese attraverso la pratica quotidiana. Purtroppo, però, la strumentalizzazione mediatica ha fatto sì che i tre giovani siano noti più per essere stati condannati recentemente a misure cautelari dal Tribunale di Torino – in quanto riconosciuti come “socialmente pericolosi” -, che per aver dato un coraggioso esempio. L’arte si è rivelata, al contrario, un mezzo più diretto in questo senso. In effetti, soprattutto negli ultimi anni, in Italia sono state portate avanti interessanti iniziative, performance, appuntamenti online, progetti, sia di tipo istituzionale che locale, per cercare di sensibilizzare il pubblico sulla questione della resistenza curda. Per quanto riguarda la capitale si possono menzionare la visitatissima mostra “Scavare fossati” al MAXXI, allestita con tavole tratte da “Kobane calling”, il fumetto sull’esperienza in Siria nel 2015 di Michele Rech (in arte Zerocalcare), la mostra “Cambiamento di Stato, Macro Asilo-Asilo di Kobane” di Nicoletta Braga tenutasi al Macro nel 2019 o, ancora , Artists for Rojava, un progetto che mirava, almeno prima del dilagare della pandemia, ad allestire una mostra su Ebay con opere di artisti più o meno celebri da vendere all’asta per ricavarne contributi da dare in beneficienza al popolo curdo.
Altri artisti internazionali, due fotografi in particolare, hanno fatto della rivoluzione curda il soggetto di alcuni dei propri lavori, fruibili ancora oggi, a qualche anno di distanza dalla presentazione, sui rispettivi portfolio online. Utilizzando la loro lente hanno cercato di catturare e fissare in una serie di scatti le esperienze individuali di chi, in prima persona, sta agendo per modificare gli equilibri sociali in Medio Oriente: in un momento storico nel quale sono sempre più numerosi i mezzi con i quali indagare il presente, l’aspetto documentario e di testimonianza della fotografia la trasforma in un’arte politica ed etica in grado di riassumere, in maniera più diretta rispetto ad altre forme, uno scenario complesso. Nonostante il sovraccarico di immagini che “subiamo” passivamente nel quotidiano, alcune fotografie, come quelle di Joey Lawrence e Murat Yazar, sono cariche di messaggi che si sedimentano nella memoria, mettendo le proprie “radici” e sollecitando lo spettatore a guardarsi dentro e a prendere una posizione, qualunque essa sia, rispetto a ciò che sta osservando.

Joey Lawrence, fotografo e regista canadese, attivo in diversi progetti globali umanitari, nel 2015 ha cercato di indagare cosa stesse succedendo in Kurdistan:
“…ho pensato di usare la forma del ritratto. E sono stato al fianco dei guerriglieri che combattevano in Iraq e in Siria contro i miliziani del gruppo Stato islamico”
ha dichiarato l’artista, il quale, attratto dalla fotografia di guerra sin da piccolo, ha deciso di recarsi in prima persona negli unici territori che godono (o godevano?) di una certa autonomia, faticosamente conquistata metro dopo metro in campo militare. Il prodotto di questo lavoro è stato We came from fire: Kurdistan’s armed struggle against Isis, un libro-catalogo sotto forma di diario, nel quale Lawrence ha raccolto scatti in medio formato con protagoniste le forze di protezione curde, le YPJ e YPG (rispettivamente composte da donne e da uomini), impegnate fianco a fianco in una guerra sanguinosissima contro i miliziani del sedicente Stato Islamico, autoproclamatosi autonomo nel 2014 e tristemente noto ai più a causa dei danni perpetrati nei principali siti archeologici e musei mediorientali. Daesh, termine dispregiativo che la popolazione locale utilizza per prendere le distanze dal cosiddetto “islam puro”, è oggi considerato un nemico comune dal quale fratelli, sorelle, studenti, rifugiati, e giovani spose scampate a matrimoni combinati continuano a difendersi.
Sono scatti profondi quelli di Lawrence, che sembrano restituire la stanchezza e l’orgoglio dei soggetti, immortalati nell’indossare una divisa simbolo di un modello sociale e di vita diverso. Scatti lontani dalle narrazioni eroiche o romanticizzate del conflitto in corso riportate dai media internazionali: due ragazze sorridono complici, appoggiandosi l’una all’altra, forse anche imbarazzate dall’obiettivo puntato loro addosso; un giovane abbronzato, con gli occhi scuri, guarda dritto dentro l’obiettivo, quasi in segno di sfida; un uomo con in mano un fucile e scarpe sporche si erge in equilibrio su una montagna di casse di plastica e sacchi… quasi ricorda la celebre Vittoria che libera la sua Nazione verso la libertà di Delacroix: fiero, solo in primo piano, sembra guidare un inte ro popolo che però, in questo caso, non è presente alle sue spalle, pur affiancandolo nella vita quotidiana. Sullo sfondo le macerie fisiche e quelle morali. La maggior parte di queste fotografie-ritratto è ambientata in spazi fatiscenti, tuttavia i protagonisti non si mettono in posa per offrire a chi li guarda la migliore versione di sé stessi, ed è forse proprio la spontaneità dell’insieme a catalizzare l’attenzione dello spettatore su di loro. L’impatto piscologico è fortissimo e ogni foto sembra fondarsi sul concetto di “verità”. Senza falsificazioni, retorica o filtri mediatici, gli scatti di Lawrence ci costringono a guardarci dentro e chiederci se siamo in grado di empatizzare con quello che ci mostrano, pur non riguardandoci in prima persona. Dunque, si è davvero trattato di un progetto significativo in quanto ha acceso un riflettore su una questione prima di tutto umanitaria e in quanto è stato accolto con favore non solo dal pubblico direttamente coinvolto, ma inaspettatamente dall’intera comunità scientifica e artistica.

Diverso è il punto di vista di chi in quei luoghi ci è nato. Murat Yazar, fotografo curdo nato nella provincia di Urfa, nella Turchia dell’est (antica Mesopotamia) e collaboratore di National Geographic e New York Times, ha lavorato alla raccolta “Ombre sul Kurdistan”. Le ombre cui allude il titolo sono sia quelle etiche, imposte del regime turco che impedisce alla minoranza etnica di esprimersi nella propria lingua, che quelle gettate sulla regione dagli esiti del secondo conflitto mondiale quando, come afferma l’artista stesso, “…la divisione del Kurdistan ha imposto dei confini tra un popolo che viveva insieme, separando intere famiglie e mettendo i curdi tra le minoranze nei quattro differenti Paesi (Turchia, Siria, Iraq e Iran) in cui sono stati divisi, mischiandoli a lingue e culture diverse. Allora, l’idea del mio progetto è unire queste quattro parti del Kurdistan in un progetto fotografico di quattro volumi: Kurdistan turco, iracheno, iraniano e siriano”.

Gli scatti di Murat sono rigorosamente in bianco e nero, per evitare che chi li osserva sia guidato, e quindi condizionato, nel ricercare dettagli e emozioni: il fotografo non sembra focalizzare la ricerca su un’analisi psicologica di donne o uomini attivi nelle operazioni militari, ma, al contrario, si concentra su episodi di vita o lavoro quotidiani, semplici, stimolando in un modo egualmente efficace empatia. I soggetti vengono ritratti in gruppi o da soli: pastori e nomadi che abitano i monti e le vallate che si scorgono all’orizzonte, bambini che giocano con un pallone di fortuna, lavoratori, donne che partecipano a feste, funerali e manifestazioni e che, in molte aree della regione, hanno conquistato con la propria militanza pari rappresentazione politica degli uomini nelle cariche amministrative e burocratiche. Al contrario degli scatti di Lawrence, in quelli di Murat nessuno sembra far caso alla macchina fotografica e, ancora, se Lawrence sembra fondare la propria ricerca sul concetto di verità e autenticità, gli scatti di Murat ci parlano invece di diversità e inclusione, oggi più che mai temi centrali nel dibattito europeo.
Che si condividano o meno le ragioni alla base della lotta sociale in Medio Oriente, la testimonianza artistica dei due fotografi rappresenta un ottimo esempio di come sia spesso possibile restituire qualcosa di complesso con la giusta sensibilità e senza retorica nella narrazione: in questo caso è il pubblico, l’osservatore, a percepire un messaggio in maniera diretta senza la mediazione imposta da filtri altrui.